RUBRICA Freeze the Future: Fiocco azzurro, è nato un ghiacciaio
Sai come nasce un ghiacciaio? Un viaggio affascinante tra neve, tempo e luce.

La genesi di un ghiacciaio parte dalla neve. Alle quote più elevate, sui versanti nord meno esposti al sole, ogni fiocco di neve che cade, sia durante le precipitazioni invernali, sia trasportato dalle valanghe, contribuisce a creare uno strato sempre più spesso di neve. Se finito l'inverno questo strato di neve riesce a superare l'estate, attraverso cicli ripetuti di fusione e ricongelamento, i cristalli di neve iniziano a modificarsi. Si formano piccole sfere di ghiaccio granuloso, chiamate firn.
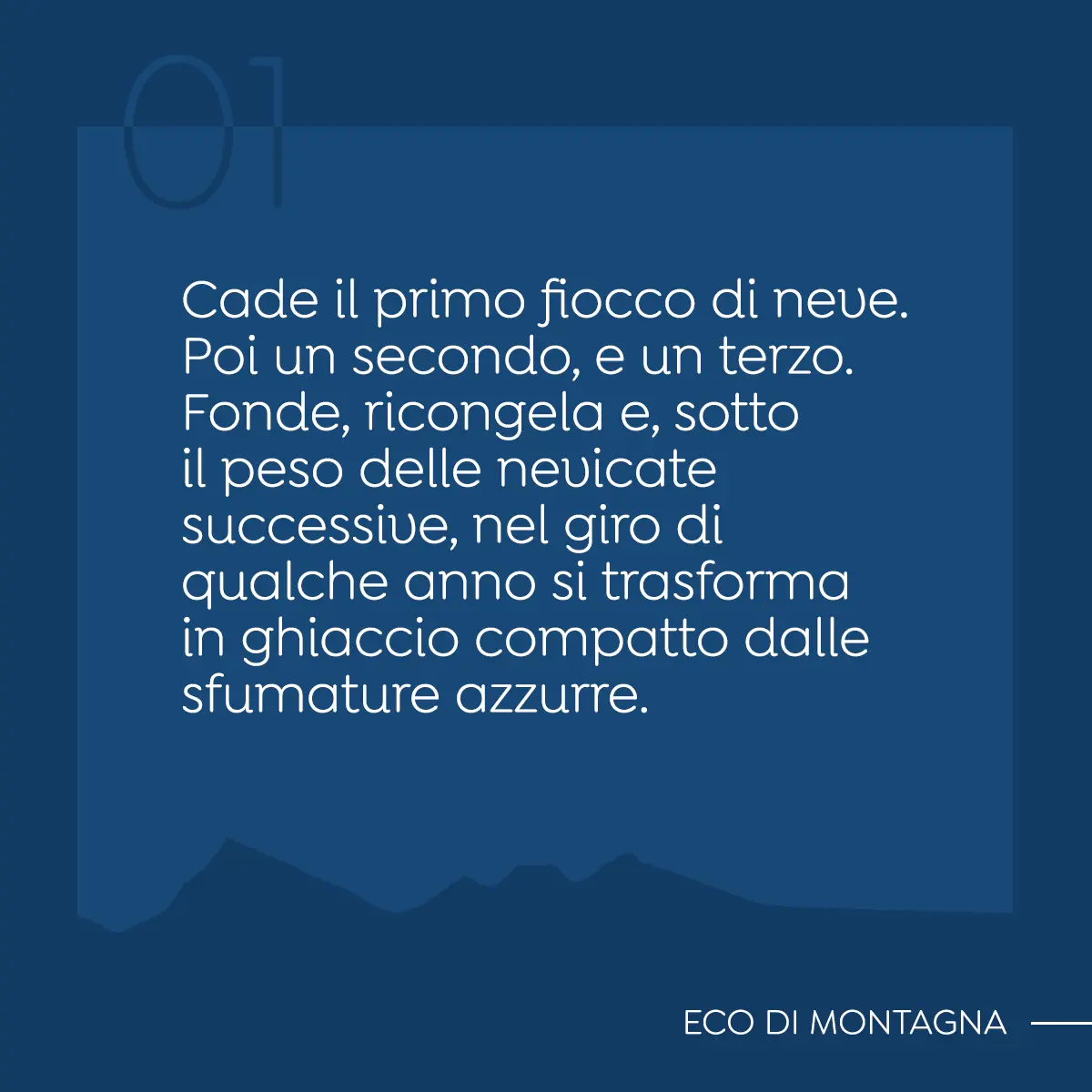
Man mano che nuove nevicate si accumulano, il firn viene compresso ulteriormente e, sotto il peso schiacciante delle nevicate successive subisce una metamorfosi: i granuli di ghiaccio si compattano e si fondono, formando un ghiaccio più denso e solido. Questo ghiaccio, inizialmente bianco e poroso, continua a trasformarsi, diventando sempre più compatto, fino a quando non assume la forma di ghiaccio blu-azzurro che caratterizza i ghiacciai.
Il colore blu dei ghiacciai è il risultato della riflessione e rifrazione della luce. Il ghiaccio compatto infatti assorbe la luce rossa dello spettro visibile e riflette le lunghezze d'onda blu, assumendo la tipica colorazione che si può osservare in molti ghiacciai.
Come si monitora un ghiacciaio?
Nonostante l’evoluzione dei sistemi di telerilevamento, il monitoraggio sul campo è ancora oggi l’attività fondamentale che consente di raccogliere i dati necessari per capire le condizioni e l’evoluzione dei ghiacciai. Per questo, ogni anno vengono organizzate campagne di rilievi nel periodo tra fine maggio e fine ottobre, dove vengono raccolti i dati riguardanti le variazioni frontali, l’accumulo di neve all’inizio dell’estate e la fusione del ghiaccio a fine estate.
Le attività di monitoraggio dei ghiacciai della Provincia di Trento sono gestite dalla Protezione civile del Trentino (Meteotrentino), dalla Commissione Glaciologica della SAT, dal MUSE e dall'Università di Padova. Le misure di arretramento frontale sono da decenni attività portate avanti in autonomia dalla SAT per conto del Comitato Glaciologico Italiano.
Dati e immagini vengono elaborati per stimare il bilancio di massa annuale dei singoli ghiacciai, cioè quanto ghiaccio e neve viene perso o acquisito. Per quanto riguarda la Provincia di Trento, i ghiacciai presi a riferimento sono Careser e de la Mare (Val di Pejo) e Mandron (Val Genova).

La misurazione frontale prevede il rilievo dell'arretramento della fronte del ghiacciaio o della misura del movimento di alcuni suoi punti laterali. La misura viene presa da punti fissi, che sono denominati "stazioni di misura". Ogni punto di misura coincide solitamente con grossi massi o punti facilmente riconoscibili anche in caso di copertura nevosa; questi punti sono identificati con dei simboli che ne riportano l'anno di posa e la direzione da cui prendere la misura. L'angolo sul piano orizzontale con cui si prende la misura è identificato come "azimut" e viene identificato anche con l'utilizzo di una bussola. La distanza viene quindi rilevata con diverse tecniche che a seconda delle condizioni sul terreno, possono essere la semplice corda metrica o i telemetri laser. Per raccogliere sempre dati più precisi possibili, questi punti mutano e si spostano nel tempo. Uno storico punto di misura è quello del ghiacciaio Adamello-Mandrone, risalente al 1899.
Negli ultimi anni l’utilizzo dei droni permette di effettuare misure sempre più precise, anche quando le fronti glaciali si ritirano in posizioni che non possono più essere raggiunte in sicurezza. I classici rilievi dalle stazioni di misura, mantengono comunque una notevole importanza in quanto vanno a continuare delle serie di dati che spesso superano il secolo.
Credito foto: Commissione Glaciologica SAT